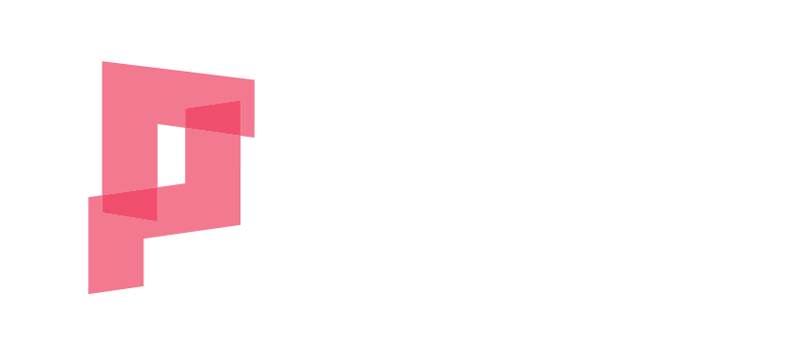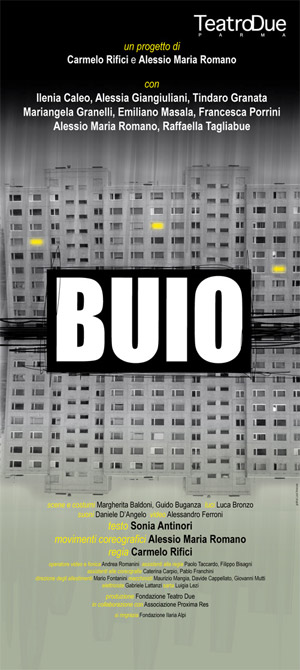Buio
un progetto di Carmelo Rifici
con Ilenia Caleo, Alessia Giangiuliani,
Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano Masala,
Francesca Porrini, Alessio Maria Romano, Raffaella Tagliabue
scene e costumi Margherita Baldoni
luci Luca Bronzo
suoni Daniele D’Angelo
video Alessandro Ferroni
testo Sonia Antinori
movimenti coreografici Alessio Maria Romano
regia Carmelo Rifici
produzione Teatro Due di Parma
in collaborazione con Proxima Res
L’incipit
Nel 2007 Carmelo Rifici ha riunito attorno a sé un gruppo di collaboratori per dar vita a un progetto che, uscendo dai consueti schemi produttivi, culminasse nella realizzazione di un lavoro originale. Il lavoro si è svolto in divenire e in più fasi.
Un lavoro in divenire
Il primo incontro è avvenuto a Milano nel 2007. I componenti della compagnia hanno studiato, improvvisato e approfondito alcune tematiche prendendo spunto da brandelli di testo, immagini, suggestioni musicali: guerra, cecità, perdita di coscienza per uso di droghe. Si è iniziato ad allenare I corpi al buio, lavorando bendati e senza vista, creando veri e propri percorsi fisici da poter ripetere da non vedenti. Ancora non si era pienamente coscienti della direzione intrapresa dal lavoro e questo ha concesso molta libertà a tutta la compagnia. Lentamente si sono delineate alcune figure e situazioni dinamiche. Durante la successiva tranche di prove, a Perugia nel 2008, l’avanzamento della scrittura drammaturgica ha consentito al regista di sperimentare i personaggi nelle diverse interpretazioni, ruotando i ruoli attraverso l’intero cast e consentendo a ciascun attore di nutrirsi delle altrui proposte, svilupparle o sconvolgerle. Nell’aprile 2009 presso il teatro di Fiorenzuola c’è stata una prima presentazione del lavoro, alcune scene e i primi “sogni”. Il debutto di Buio è avvenuto presso il Teatro Due di Parma nell’ottobre 2010.
Due testi in un testo
La bellezza del testo di Sonia Antinori sta nella sua delicatezza nel raccontare le situazioni. Il testo ha come riferimento la tragedia classica, ma il riferimento non viene mai esplicitato, mai direttamente suggerito. In questo testo non ci sono eroi, non ci sono personaggi fuori dal comune, ma solo uomini malati nell’anima in cerca di una cura, di una riappacificazione col mondo, e con loro stessi. La malattia è una strana impossibilità alla verità. Le storie narrate infatti sono intrecciate tra di loro attraverso una fitta rete di bugie.
Carmelo Rifici
Nella prima elaborazione del testo, alcune scene sono state scritte estesamente, altre soltanto come canovaccio. In ambedue i casi il lavoro individuale dell’autrice è stato sottoposto alla verifica del gruppo. Si è espressa la volontà di articolarlo in zone cosiddette “diurne”, che raccontano le storie concrete dei protagonisti, e nei “notturni”, momenti di tempo sospeso in cui i personaggi si incontrano come nelle isole del sogno. Se le vicende “diurne” sono costruite su dialoghi secchi e quotidiani dell’autrice Sonia Antinori, i “notturni” hanno previsto una drammaturgia fisica, a cura del coreografo Alessio Maria Romano. Il risultato è una drammaturgia che contiene al suo interno due “testi”: quello della parola scritta e poi interpretata, quello dello spazio del corpo abitato dai sogni dei personaggi.
I tre nuclei narrativi di Buio
1.Paolo torna da una missione in Somalia in cui ha visto morire il suo migliore amico. Non sentendosi a suo agio nella casa paterna, va a rifugiarsi dalla sorella Teresa, che sta vivendo una difficile situazione personale con il fidanzato. Paolo tenta di ricostruirsi una vita grazie a questo affetto di sempre, ma è inabile a reinserirsi in un ritmo di vita di una qualche regolarità. Alla notizia che la casa della sorella è stata messa in vendita sprofonda nell’angoscia. Nella sua mente incombono immagini dell’amico morto e la violenza della memoria lo spinge a ricordi dai simbolismi esasperati.
2.Carlo è un autore teatrale sui quarant’anni malato di leucemia. In seguito ad una prima fase di cure chemioterapiche decide di interrompere le sedute e di rinunciare all’intervento per il trapianto del midollo osseo, consegnandosi a un gruppo di terapie alternative in cui fa uso di sostanze allucinogene. La compagna Piera tenta disperatamente di convincerlo a cambiare idea, ma lui è irremovibile.
3.Selma è un’attrice bosniaca non vedente. Durante l’assedio di Sarajevo una granata le è esplosa in giardino mentre stava giocando con il figlio. Il bambino è morto e lei ha perso la vista. Dopo la tragedia si è trasferita in Italia, paese d’origine di suo padre. Daniel, un operaio romeno va a casa sua per dei lavori di manutenzione. Tra i due nasce spontaneamente un dialogo, che presto diviene piacevole consuetudine, tanto che la donna accetta di ospitarlo nella dependance della sua casa con quella che ritiene essere sua sorella. Ma la fiducia di Selma sarà tradita dalla scoperta che la giovane donna romena è in realtà la moglie di Daniel, incinta al sesto mese, bisognosa di trovare un posto dove rifugiarsi fino al parto.
Il lavoro fisico e i notturni
Ci chiedevamo cosa dovessimo esattamente fare. Allenavamo il corpo, trovavamo infiniti “codici” e infiniti “segni”, ma come rappresentare quel mondo? Questa una delle bellezze del particolare momento di studio che ci siamo presi, ovvero porsi domande e cercare noi da soli ricordando, provando e sicuramente sbagliando. Abbiamo studiato cosa sono i sogni, ne abbiamo inventati un numero infinito, ne abbiamo raccontati di propri e ne inventeremo ancora. Oggi abbiamo trovato il luogo del sogno. Un luogo vuoto, la nostra stessa scena, in cui muoverci quasi liberamente.
Alessio Maria Romano
Il “buio” psicofisico che le parole esplorano trova una forma al limite della danza nei “notturni”, allegorie di quegli stati di allucinazione in cui ci sembra di avvicinarci inaspettatamente all’inconoscibile per poi scoprire che quello, come nel paradosso della tartaruga di Zenone, si è spostato di una misura infinitesimale e che la distanza resta incolmabile. Il lavoro fisico ha avuto fin dall’inizio un alto significato espressivo, tanto da dilatare le maglie della stesura testuale e presupporre intere scene di puro movimento. Mentre nascevano i personaggi e il testo, in parallelo si è svolta la ricerca sui sogni, ovvero lo studio sulla modalità di azione di un corpo e di un pensiero nel mondo onirico. I tentativi e gli aprocci sono stati diversi e numerosi. Abbiamo provato ad “agire” i sogni e gli incubi di ciascuno, abbiamo lavorato sul movimento astratto, sul gesto quotidiano e concreto, sulla cancellazione di entrambi per entrare nello stato dello “stare” dell “esserci”. Questo lento procedere, le continue verifiche delle scene e dei linguaggi hanno fatto crescere l’autoralità dell’intero gruppo senza intaccare le pertinenze specifiche, ma sottoponendole a un persistente confronto.